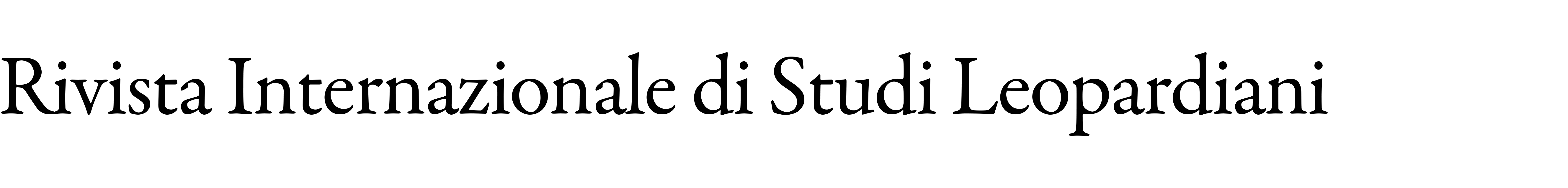Call for papers
Call for paper n. 11
La RISL, Rivista Internazionale di Studi Leopardiani, è l’unico periodico scientifico dedicato specificatamente a Giacomo Leopardi. Fondata nel 1999 da Emilio Speciale e da lui diretta fino alla sua prematura scomparsa nel maggio 2017, la RISL prosegue ora le sue pubblicazioni sotto la nuova direzione di Tatiana Crivelli e Patrizia Landi, grazie alla preziosa collaborazione della casa editrice Franco Cesati di Firenze.
La rivista intende rispettare la linea editoriale inaugurata dal suo fondatore e continuerà dunque ad accogliere e proporre «con la massima apertura ideologica, interventi critici scelti esclusivamente in base alla loro scientificità, cercando di porsi come sede di discussione problematica, informativa e vivace» su uno dei maggiori poeti e pensatori italiani, non solo dell’Ottocento.
Per mantenere fede a questi propositi riteniamo necessario progettare numeri tematici, a cominciare dal numero 11 (2018), primo della nuova direzione.
Qui di seguito il relativo Call for Papers.
Giacomo Leopardi e l’esperienza del sensibile
“Di modo che i sensi dell’uomo sono capaci di piacere
anche presso all’estinguersi”
Nell’opera di Leopardi la cosiddetta esperienza del sensibile non solo orienta in modo decisivo la riflessione epistemologica e l’elaborazione filosofica della teoria del piacere, ma è anche sottesa a molte immagini della scrittura creativa in prosa e in versi. La percezione sensoriale delle cose del mondo e dell’essere umano rappresenta, infatti, uno dei principali strumenti di apprendimento e di conoscenza. Essa costituisce uno degli aspetti nodali – particolarmente innovativi rispetto alla tradizione letteraria e filosofica dell’Italia ottocentesca – della poetica leopardiana, capace di dare “corpo” e “sostanza” anche a quanto è connesso alla pura immaginazione e, così, di descrivere l’invisibile tramite il visibile, l’intangibile tramite il tangibile. In Leopardi, infatti – come ben sottolineava Italo Calvino nelle sue Proposte per il nuovo millennio citando le pagine 1744-1746 dello Zibaldone – anche la teoria del vago e dell’indefinito si esprime attraverso il sapiente utilizzo di elementi sensibili. Né si può dimenticare che pure la Natura, parte di quella materia da cui secondo Leopardi tutto ha origine, può essere conosciuta dal genere umano solo per mezzo dei sensi, come bene insegna la vana fuga dell’Islandese tanto dall’“intensità del freddo” quanto dall’“ardore estremo della state”.
Questo primo numero tematico vuole far convergere differenti approcci disciplinari per studiare, nelle sue varie declinazioni, l’influenza che la percezione sensoriale ha avuto nell’ambito della riflessione poetica, filosofica, artistica, linguistica e scientifica di Leopardi.
Tra i possibili ambiti di ricerca:
- L’utilizzo di immagini sensoriali e la lingua dei “sensi” in poesia.
- La percezione sensoriale come strumento di conoscenza filosofica. Possibili campi di indagine sono sia la consonanza con i principi del sensismo sei-settecentesco italiano ed europeo, sia l’anticipazione leopardiana di alcune fondamentali questioni affrontate dalla filosofia moderna, dal materialismo novecentesco alla riflessione biopolitica contemporanea.
- I riverberi della percezione sensoriale e dell’esperienza delle cose del mondo nella scrittura privata, con una particolare attenzione all’epistolario.
- Vita del corpo e rappresentazione della corporeità sia nelle opere di Leopardi, sia nelle opere a lui dedicate (letteratura, cinema, teatro, pittura e scultura, …).
- Riflessioni sulla “fisicità” dei linguaggi, in particolare della lingua italiana intesa nelle sue dimensioni materiali (adattabilità, malleabilità, pronuncia, radici etimologiche e filologiche, ricchezza semantica, …).
- Retorica e percezione sensoriale.
- Immagini e percezione sensoriale: creazione e ricezione.
- La poetica della fisicità del mondo elaborata attraverso l’osservazione dei processi tecnologici e scientifici.
Si prega di inviare entro il 31 marzo 2018 un abstract di 250 parole circa e una breve nota bio-bibliografica ai seguenti indirizzi mail:
La decisione della Direzione e del Comitato scientifico sarà comunicata entro la fine di aprile. Al momento dell’accettazione saranno inviate anche le Norme editoriali.
I contributi non dovranno superare le 50.000 battute, spazi inclusi, e dovranno pervenire ai medesimi indirizzi email indicati sopra entro il 31 agosto 2018.
Ogni contributo sarà soggetto a double blind peer review.
Call for paper n. 13
Giacomo Leopardi e le rappresentazioni sette-ottocentesche della natura
O natura, o natura, |Perchè non rendi poi | Quel che prometti allor? perchè di tanto | Inganni i figli tuoi?
Madre temuta e pianta | dal nascer già dell’animal famiglia, |Natura, illaudabil meraviglia, |
che per uccider partorisci e nutri.
La natura costituisce uno dei nuclei fondamentali sia della elaborazione poetica, sia della riflessione ermeneutica di Leopardi, tanto nella veste di ‘spettacolo’ ambientale, molte volte lunare, che fa da palcoscenico, spesso contrastivo, ai “moti” dell’animo, quanto nella veste di ente generatore che materialmente e meccanicisticamente crea, dimenticandosi di quanti ha creato (esseri umani, animali, piante) e destinandoli a sofferenza certa.
La complessità della raffigurazione leopardiana della natura – madre benevola nelle epoche antiche e durante la fanciullezza, madre indifferente nelle epoche moderne e nell’età adulta – si appoggia su ampie letture filosofiche e letterarie, nonché su una potente capacità di osservazione del mondo circostante e della ricca iconografia del tempo. Voltaire e il suo Poema sul disastro di Lisbona, Thomas e la sua Ode sul tempo, Il Sistema della natura di d’Holbach ma anche le opere di Pluche e di Buffon, soltanto per citarne alcune, interagiscono – oggi si direbbe in modo “transmediale” – con le rappresentazioni artistiche letterarie e visive, generando in Leopardi una scrittura complessa, multiforme e variegata, capace di attraversare generi e forme tra loro diverse, e che diventa ancora più espressiva e composita durante gli anni trascorsi a Napoli. Lì, la compenetrazione tra osservazione diretta del paesaggio marino e vesuviano e le sue descrizioni, in particolare quelle prodotte da viaggiatori e viaggiatrici stranieri/e, diventa materiale “attivo” per la composizione tanto dei Paralipomeni quanto della Ginestra e del Tramonto della luna.
Il vasto ambito delle raffigurazioni poetiche e delle riflessioni filosofiche che Leopardi dedica al tema della natura è, come noto, uno dei capisaldi della critica leopardiana, che vi è esercitata su più fronti. Questo numero tematico ha tuttavia l’ambizione di sondare in modo puntuale un aspetto ancora bisognoso di approfondimento, ovvero il concetto e la rappresentazione della natura connessi al contesto culturale di quella modernità a cui Leopardi può fare riferimento. Si tratterà di analizzare, insomma, l’influenza esercitata dalla trattatistica scientifica e filosofica, ma anche dalla produzione artistica e poetica a cavallo tra Sette e Ottocento sull’elaborazione delle diverse idee leopardiane di natura. Facendo convergere differenti approcci e differenti metodologie di indagine – comparatistica, ecocritica, filologia, ermeneutica, linguistica, tematica, studi culturali, stilistica,… – i saggi che comporranno il numero 13 della RISL dovranno poter gettare nuova luce sul Leopardi lettore (ad esempio di immagini complesse, filosofiche e insieme naturalistiche, come quella del giardino nella tradizione settecentesca, riformatrice e/o illuminista; o della natura filtrata dalla poesia dell’Arcadia); sul Leopardi osservatore (ad esempio della scultura di Canova e dei suoi discepoli, come quel Pietro Tenerani, ispiratore delle due sepolcrali); sul Leopardi ascoltare e spettatore (ad esempio della messa in scena della natura romantica nella rossiniana Donna del lago); sul Leopardi traduttore (che per via indiretta o diretta, soprattutto tramite le riviste del tempo, legge e apprezza, oltre ai classici, anche la cultura europea a lui contemporanea); ecc.
Si prega di inviare entro il 28 febbraio un abstract di 250 parole circa e una breve nota bio-bibliografica al seguente indirizzo mail:
La decisione della Direzione e del Comitato scientifico sarà comunicata entro il 15 marzo. Al momento dell’accettazione saranno inviate anche le Norme editoriali.
I contributi non dovranno superare le 60.000 battute, spazi inclusi (ca. 10.000 parole); e dovranno pervenire al medesimo indirizzo email sopra indicato entro il 15 ottobre 2020.
Ogni contributo sarà soggetto a double blind peer review.
Call for paper n. 15
La RISL, Rivista Internazionale di Studi Leopardiani, è l’unico periodico scientifico dedicato specificatamente a Giacomo Leopardi. Fondata nel 1999 da Emilio Speciale e da lui diretta fino alla sua prematura scomparsa nel maggio 2017, la RISL prosegue le sue pubblicazioni, anche in versione digitale Open Access, sotto la direzione di Tatiana Crivelli e Patrizia Landi, grazie alla preziosa collaborazione della casa editrice Mimesis.
La rivista intende rispettare la linea editoriale inaugurata dal suo fondatore e continua dunque ad accogliere e proporre «con la massima apertura ideologica, interventi critici scelti esclusivamente in base alla loro scientificità, cercando di porsi come sede di discussione problematica, informativa e vivace» su uno dei maggiori poeti e pensatori italiani, non solo dell’Ottocento.
Per mantenere fede a questi propositi a cominciare dal primo numero della nuova direzione sono stati progettati, alternandoli ai fascicoli tradizionali, anche dei numeri tematici. Dopo aver proposto un’ampia rilessione sul tema dell’esperienza del sensibile con il fascicolo 11 del 2018, e sul tema della natura con il fascicolo 13 del 2020, si intende ora portare l’attenzione al capolavoro in prosa di Leopardi, con un numero dedicato a studiare da nuovi punti di vista le Operette morali.
Qui di seguito il relativo Call for Papers.
NUOVI SGUARDI SULLE OPERETTE MORALI
Dell’attenzione critica stimolata dalla traduzione inglese dello Zibaldone per la prosa filosofica di Leopardi le Operette morali hanno beneficiato solo marginalmente e, fatta eccezione per gli aspetti filologici, il capolavoro a cui l’autore affida il compito di innovare «lo stile e le bellezze parziali della satira fina» resta ancora, per molti versi, da indagare.
Nel terzo numero tematico della RISL dovranno pertanto convergere riflessioni teoriche e suggerimenti puntuali per il commento ai testi, che, interagendo, offriranno una disamina innovativa della raccolta leopardiana, tesa ad ampliare le conoscenze circa modelli, finalità e rilevanza attuale del discorso delle Operette.
Tra i possibili ambiti di ricerca:
- Proposte di riflessioni teoriche e/o di puntuali letture innovative delle Operette in chiave postcoloniale, di genere, ecocritica, decostruzionista e, in generale, poststrutturalista e intersezionale.
- Riflessioni sul macrotesto e sul genere letterario delle Operette.
- Studi di taglio comparatistico che inseriscano le Operette nel quadro della letteratura europea coeva.
- Studi interdisciplinari (scienza, filosofia, arte, moda, musica, ecc.) che illustrino l’enciclopedia culturale di riferimento dell’opera.
- Riflessioni di ordine stilistico e/o retorico.
- Studi che illuminino su nuovi rapporti inter- e intratestuali.
- Studi sulla ricezione e il riutilizzo delle Operette nella cultura del Novecento sia in Italia sia all’estero.
Si prega di inviare entro il 22 aprile 2022 un abstract di 250 parole circa e una breve nota bio-bibliografica al seguente indirizzo email: risl.direzione@ gmail.com.
La decisione della Direzione e del Comitato scientifico sarà comunicata entro il 15 maggio 2022. Al momento dell’accettazione saranno inviate anche le Norme editoriali.
I contributi non dovranno superare le 50.000 battute, spazi inclusi (ca. 8.000 parole), e dovranno pervenire al medesimo indirizzo email indicato sopra entro il 30 settembre 2022.
Ogni contributo sarà soggetto a double blind peer review.
Call for paper n. 17
Paesaggio urbano e paesaggio naturale: per una estetica della visione in Leopardi
Il rapporto leopardiano col paesaggio è condizionato dalla concezione tanto della natura (in tutta la sua complessità e varietà) quanto della società. Nell’indagare il difficile equilibrio tra organico e inorganico, e l’articolato nesso tra paesaggio urbano e paesaggio naturale, Leopardi affronta alla radice il problema della dialettica tra antichi e moderni e quindi, in ultima analisi, tra vita e morte, costruendo al contempo una vera e propria estetica della visione, modulata su livelli e piani diversi (pure intertestuali), anche a seconda del genere letterario scelto.
Il nuovo numero della RISL-Rivista Internazionale di Studi Leopardiani per l’anno 2024 si focalizzerà dunque sulla messa a fuoco dell’estetica leopardiana della visione attraverso lo studio proprio del rapporto tra io e paesaggio (urbano e naturale), in un complesso gioco di coperture e scoperture, di impedimenti e liberazioni. Non senza dimenticare che in Leopardi è presente un’anima ecologista ante litteram: si pensi alle pagine dello Zibaldone in cui si discute del rischio dello sfruttamento delle foreste, pagine connesse al più ampio tema dello sfruttamento dell’uomo sull’uomo che aprono sia a un’indagine eco-critica del pensiero leopardiano sia alla rilettura post-umana delle Operette morali e dei Canti.
Si prega di inviare entro il 31 gennaio 2024 un abstract di 250 parole circa e una breve nota bio-bibliografica al seguente indirizzo mail:
La decisione della Direzione e del Comitato scientifico sarà comunicata entro il 15 febbraio. Al momento dell’accettazione saranno inviate anche le Norme editoriali.
I contributi non dovranno superare le 60.000 battute, spazi inclusi (ca. 10.000 parole); e dovranno pervenire al medesimo indirizzo email sopra indicato entro il 15 luglio.
Ogni contributo sarà soggetto a double blind peer review.
Call for paper n. 18
La RISL-Rivista Internazionale di Studi Leopardiani, pubblicata annualmente da Mimesis edizioni (in Open Access), è l’unico periodico scientifico di Classe A dedicato specificatamente a Giacomo Leopardi, e presenta alternativamente numeri tematici e numeri liberi.
Sin dalla sua fondazione la RISL è volta ad accogliere «con la massima apertura ideologica, interventi critici scelti esclusivamente in base alla loro scientificità, cercando di porsi come sede di discussione problematica, informativa e vivace» su uno dei maggiori poeti e pensatori italiani, non solo dell’Ottocento.
Per il numero 18 (2025), a tema libero, la direzione e il comitato scientifico RISL sono lieti di invitare a sottoporre alla rivista contributi dedicati a esplorare aspetti vari dell’opera leopardiana, purché conformi alla linea editoriale adottata dalla rivista, in italiano o nelle maggiori lingue europee.
I contributi dovranno seguire scrupolosamente i Criteri editoriali pubblicati in coda all’ultimo numero della rivista (scaricabile gratuitamente all’indirizzo: https://www.mimesisedizioni.it/libro/9791222317922) e non dovranno superare le 50.000-60.000 battute, spazi inclusi. Dovranno essere accompagnati da:
- abstract sia in lingua inglese sia in lingua italiana, di circa 800-1000 caratteri, spazi inclusi;
- 5-6 parole-chiave/keywords;
- una breve nota bio-bibliografica, di ca 900-1000 caratteri, spazi inclusi.
I contributi dovranno essere inviati entro il 31 agosto 2025 all’indirizzo sotto indicato:
Ogni contributo sarà soggetto a double blind peer review. La decisione della direzione e del comitato scientifico, insieme ai giudizi scaturiti dalla revisione, sarà comunicata entro la metà di ottobre.
Si specifica che la RISL ha ottenuto il riconoscimento ANVUR come rivista di Classe A per i seguenti settori: 10/F1 (Letteratura italiana); 10/F2 (Letteratura italiana contemporanea; e 10/F4 (Critica letteraria e letterature comparate).
Call for paper n. 19
Oltre i Canti. La poesia di Giacomo Leopardi come pratica, forma e pensiero
Questo numero monografico della RISL-Rivista Internazionale di Studi Leopardiani intende proporre uno sguardo ampio e articolato sulla poesia leopardiana, includendo ma insieme superando l’identificazione con il corpus dei Canti e accostandola come un insieme di pratiche testuali, riflessioni teoriche, scelte formali e costruzioni editoriali che attraversano l’intera produzione dell’autore. Il volume mira a esplorare la poesia leopardiana non solo nel suo esito, ma come processo, includendo lo studio di testi giovanili, traduzioni e imitazioni, componimenti occasionali, riflessioni metapoetiche, prefazioni, note editoriali, progetti di raccolta e riscritture, nonché il rapporto con le fonti, i modelli e le tradizioni letterarie antiche e moderne, in una prospettiva che faccia emergere il Leopardi poeta-filologo e poeta-editore, profondamente consapevole della storicità delle forme e del valore teorico della pratica poetica.
Si accoglieranno contributi dedicati ai seguenti temi, da intendersi come indicativi e non esclusivi:
- la formazione poetica giovanile e la funzione delle traduzioni e imitazioni dai classici;
- le fonti e i modelli della poesia leopardiana (antichi, moderni, italiani ed europei);
- la riflessione sulla metrica, sulle forme poetiche e sullo stile;
- il rapporto tra poesia e pensiero filosofico, anche in relazione allo Zibaldone;
- la dimensione metapoetica;
- la costruzione editoriale dei Canti e di altri corpora poetici (prefazioni, ordinamenti, riscritture);
- testi poetici marginali, occasionali o incompiuti e i confini del “poetico”;
- la poesia come pratica storica, linguistica e teorica.
Saranno valutati con particolare interesse i contributi che mettano in dialogo critica letteraria, filologia, storia dell’editoria e teoria della letteratura, o che propongano letture capaci di ridefinire il canone leopardiano a partire da materiali meno frequentati.
I contributi, in italiano o nelle maggiori lingue europee, dovranno seguire scrupolosamente i Criteri editoriali pubblicati in coda a ogni fascicolo della rivista (l’ultimo numero è consultabile gratuitamente qui: https://mimesisjournals.com/ojs/index.php.risl/index) e non dovranno superare le 50.000-60.000 battute, spazi inclusi. Dovranno essere accompagnati da:
- abstract sia in lingua inglese sia in lingua italiana, di circa 800-1000 caratteri, spazi inclusi;
- 5-6 parole-chiave/keywords;
- una breve nota bio-bibliografica, di ca 900-1000 caratteri, spazi inclusi.
I contributi dovranno essere inviati entro il 15 luglio 2026 all’indirizzo:
Ogni contributo sarà soggetto a double blind peer review. La decisione della direzione e del comitato scientifico, insieme ai giudizi scaturiti dalla revisione, sarà comunicata ai primi di settembre.
La RISL-Rivista Internazionale di Studi Leopardiani, pubblicata annualmente da Mimesis edizioni e disponibile anche in Open Access, è l’unico periodico scientifico di classe A dedicato specificatamente a Giacomo Leopardi. La rivista ha ottenuto il riconoscimento ANVUR per i seguenti settori: ITAL-01/A-Letteratura italiana; LICO-01-/A-Letteratura italiana contemporanea; COMP-01/A-Critica letteraria e letterature comparate.